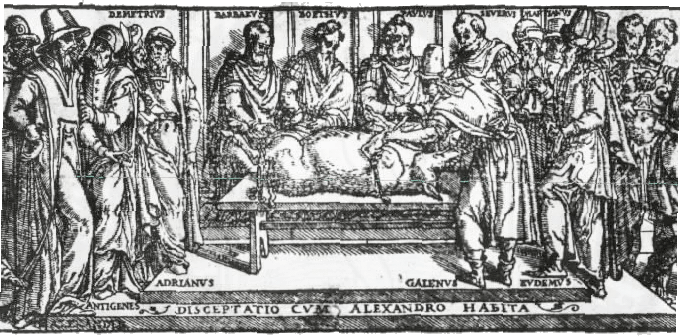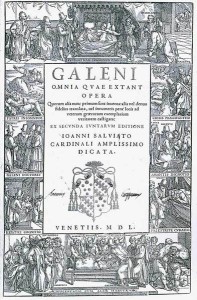La medicina in Roma ha attraversato tre periodi: uno di origine autoctona, italica, a cui si può riportare anche parte della medicina etrusca; uno di transizione, misto di elementi autoctoni e di importazione greca; e un ultimo periodo dotto “delle scuole”, in cui la medicina si raffi nò in indirizzi medici di origine greca. Prima della comparsa di Galeno ci furono personaggi che si avvicinarono all’ars medica, come Caio Plinio II, ma anche Cicerone, l’architetto Vitruvio vissuto al tempo di Adriano, Marco Terenzio Varrone, Tito Lucrezio Caro, che in epoche differenti scrissero e si interessarono di medicina pur essendo loro campioni in altre discipline.
La comparsa sulla scena di Galeno, veramente un colosso della medicina in epoca romana, ha costretto tutto gli storici ad un lavoro minuzioso ed imponente per poter in qualche modo delineare la sua importanza. Galeno si presenta con una mentalità medica completa che si plasma nella costante visione dell’indagine anatomica e della sperimentazione condotta in laboratorio. Per esempio, le diagnosi da lui formulate denunciano talvolta la nozione della sede dell’alterata funzione dell’organo malato, appresa in sede sperimentale. La patologia che egli concepisce è il risultato di una geniale funzione delle dottrine allora vigenti attraverso un ragionamento, assolutamente antesignano, da perfetto positivista scientifico. Galeno nacque nell’anno 129 a Pergamo, in Asia Minore, e iniziò i suoi studi con la filosofia; successivamente si spostò a Smirne e a Corinto ed infine si fermò lungamente ad Alessandria. Giunge a Roma preceduto già dalla sua fama, ciò gli suscitò onori ed invidie: alcuni periodi furono difficili, tanto che per un breve periodo ritornò in patria, ma successivamente fu richiamato. Si pensa sia morto nell’anno 201, forse a Roma o a Pergamo o in Sicilia.
Egli scrisse almeno 400 trattati, molti dei quali sono andati persi in un incendio: di tutta questa enorme produzione oggi rimangono 83 scritti ritenuti originali, 19 dubbi e 15 commentari degli scritti ippocratici. Galeno scrisse le sue opere originali in greco; la traduzione fu fatta successivamente dagli arabi che in molti casi modificarono ampiamente il testo originale. I libri galenici greci furono poi tradotti in latino e stampati nel 1541. La copia più ricercata è quella però del 1525, che porta a fronte il testo greco e la traduzione in latino.
In questo nostro breve viaggio nell’ars medica ci dobbiamo limitare a qualche flash e quindi ad una doverosa sintesi perché l’approccio completo sarebbe inesauribile. L’opera di Galeno è molteplice e si interessa di anatomia, di fisiologia, di patologia, di clinica, di terapia, di igiene, di medicina legale e anche di esegesi e filosofia. Se Galeno avesse avuto le possibilità settorie di cui godettero gli anatomisti del Rinascimento, la sua sarebbe stata veramente un’anatomia tecnicamente superiore. Purtroppo egli vive in un’epoca in cui esistevano superstizioni che impedivano l’approccio scientifico al cadavere che occasionalmente fosse venuto alla sua attenzione, tanto che molte delle sue scoperte sono delle deduzioni geniali dalla dissezione di animali e la sua grande capacità sta nel comporre un viraggio morfologico dalla struttura animale alla struttura umana. Questo tipo di trasposizione fa sì che egli cadesse in sillogismi errati come quando, ad esempio, descrive l’utero della donna, che probabilmente non aveva mai visto, uguale a quello della vacca, perché entrambi avevano la funzione del partorire.
Egli giunge a superare il concetto platonico di scienza definendo l’anatomia non solo come struttura e morfologia, ma come elemento funzionale. Insomma, nel suo percorso anatomico getta le basi della fisiologia. Come dicevamo, molte delle sue opere sono andate perdute ma emerge in modo chiaro come Galeno con le sue dissezioni studiasse l’osteologia, la miologia, l’angiologia e la neurologia. Riuscì, insomma, in un’epoca così “primitiva” agli occhi nostri, a descrivere la morfologia ossea, a isolare i ventri muscolari e il percorso di numerosi nervi periferici. Fu il primo che negò che l’origine dei nervi fosse il cuore, come allora si diceva, affermando che
essi derivavano dal cervello attraverso il midollo spinale. Se ci si sofferma sulla sua immensa capacità, si troveranno descrizioni legate ai nervi cranici, giungendo a intuire la duplicità degli stessi, interessanti i due emisomi del capo. Nell’angiologia non fece progressi importanti rispetto alle nozioni che già si sapevano e rimase anche lui dell’idea che dal cuore sorgessero le arterie e dal fegato le vene. Ma possiamo noi trovare un difetto in questo?
Come si diceva, la fisiologia è diffusa in tutta la sua opera perché Galeno era affascinato dalla funzione e dei vari meccanismi che comportava la stessa. Anch’egli parte dal concetto umorale ippocratico, ma è in grado di elaborare nuove idee confortandole con gli studi anatomici. Egli fu l’antesignano della sperimentazione, infatti la fisiologia di Galeno ha il merito di essere spesso suffragata dalla sperimentazione, almeno quando l’esperimento è possibile. Attraverso numerosi esperimenti sull’animale egli cominciò ad intuire la funzione secretoria del rene attraverso gli ureteri e molto importanti furono le sue scoperte sulla circolazione fetale e come questa fosse intimamente legata al corpo femminile. Tutte queste osservazioni, come dicevamo prima, tramite un percorso sillogico lo condussero a estrapolare l’esatto funzionamento anche del corpo umano: ne risulta che Galeno diviene per primo il maestro di quella scuola sperimentale che è presente ancora ai giorni nostri.
Oltre ad aver capito la funzione del midollo spinale e di come le lesioni dello stesso portassero a delle paralisi periferiche, si interessò anche della respirazione e studiò i movimenti della gabbia toracica, dei muscoli intercostali e del diaframma, anche se di quest’ultimo muscolo non riuscì a cogliere la grande importanza. Ecco dove sorge l’aspetto umorale: l’aria inspirata si trasforma, una volta introdotto nell’organismo, in vari pneumi che si dirigono e servono per tutte le funzioni dell’interno organismo.
Una parte ampia fu dedicata all’integrazione tra circolazione e alimentazione: lo stomaco e l’intestino servono a trasformare il cibo, il quale poi passa nel sangue e giunge ai vari organi. In questo modo corresse diversi errori metodologici di alcune scuole che definivano in modo più o meno bizzarro il percorso degli alimenti. Si rese conto dell’importanza del fegato come centro di vita, anche se non riuscì a dimostrare (non esisteva il microscopio) le sue esatte funzioni.
È forse l’unica parte in cui gli studi di Galeno sono limitati: come già dicevamo, l’angiologia era stata studiata da altre scuole e solamente molto tempo dopo gli anatomisti riuscirono a suddividere con certezza il piccolo e il grande circolo e la circolazione periferica arteriosa che si spegne e rinasce nella circolazione periferica di ritorno venosa.
Per quanto riguarda la patologia e la clinica va detto che il Galeno patologo è nettamente al di sotto del Galeno anatomista e fisiologo. Verosimilmente tutto nasce dal fatto che l’immensa capacità di volersi rendere conto ad ogni costo del meccanismo causa-effetto ha forse tolto quella chiarezza e semplicità che appare ad esempio in Ippocrate. Per Galeno la malattia è uno stato del corpo in cui si trovano lese le funzioni, quindi lesione di un organo equivale a lesione della sua funzione, onde per cui ad ogni malattia corrisponde una lesione organica. I sintomi costituiscono gli effetti della malattia. Partendo da questi concetti, Galeno divise le malattie in quelle delle parti semplici o similari e in quelle degli organi, a sua volta formati dalle parti semplici (arterie, vene, nervi, ossa, cartilagini, muscoli) ed infine le malattie traumatiche. La patologia galenica è quindi il risultato di una fusione delle scuole preesistenti: umorale nel suo fondamento, meccanica, o meglio atomistica, in alcune contingenze.
Egli prese spunto per formulare la teoria della ametria, cioè alterazione dei poli che si trovano fra gli atomi, mentre dalla più antica idea umorale prende il concetto della intemperie. Su queste due basi, oggi più modernamente chiamate come costituzione e temperamento, egli fonda gran parte della sua patologia. A questa semplicità di vedute si aggiungono però una complessissima
pletora di termini, di concause che risentono dell’influsso aristotelico e che conducono a illazioni filosofiche e sillogismi. In tal modo la patologia galenica è un pericoloso gioco di parole, di nomi, di qualità di cause antecedenti, congiunte, prossime, che portano direttamente ad un campo diagnostico astratto.
Questo lo condusse a tutta una serie di suddivisioni, spesso poco comprensibili, sull’eziologia morbosa, legate strettamente al concetto umorale e all’alterazione funzionale. Anche i sintomi a loro volta erano suddivisi in tre generi che, a cascata, venivano suddivisi a loro volta in sottogeneri. Siamo di fronte ad una trasformazione della medicina ippocratica: i classici umori ellenici si trasformano perché ognuno di esso ha dato luogo ad altre varietà. Questa suddivisione e parcellizzazione dell’eziologia e del sintomo conduce spesso a conclusioni che si discostano dalla realtà della malattia. Ben differente invece Galeno si mostra nella clinica. In questa egli fu di una minuzia senza pari. Egli ricercò il sintomo fino allo scrupolo, la sua azione sull’economia generale e la sua ripercussione su ogni apparato dell’organismo: osservazioni minuziose che spesso vengono infarcite di discussioni teoriche e formule filosofiche.
Da questa minuzia, che potremmo addirittura definire ossessiva, deriva la necessità dell’osservazione attentissima del malato, che conduce a diagnosi raffinate ancora oggi meravigliose nella loro didattica. Concludendo, si può dire che con Galeno nasce la vera semeiotica, che è il modo con cui ogni bravo medico è in grado di poter fare diagnosi corretta sul proprio paziente. Come si diceva poc’anzi, Galeno non emerse particolarmente nell’arte chirurgica, verosimilmente lasciata ai “medici militari”, mentre è importante ricordare che fu il primo a fare nei suoi molteplici libri qualche allusione a quesiti i medicina forense e quindi a questioni medicolegali. “Per molte ragioni gli uomini simulano di essere malati”, dice il grande medico, “per quale motivo lo fanno? E come possiamo noi fare per scoprire questi inganni?”
Il Galeno terapeuta parte dal concetto del contraria contrariis (l’esatto opposto della medicina omeopatica): rimedio caldo nelle malattia da perfrigerazione, evacuazione nelle raccolte ematiche o purulente, ecc. Non è così semplice come si può pensare, dato che questo tipo di approccio si innesta sui concetti umorali da cui dipende la corretta impostazione terapeutica. Purtroppo questo è un limite grande perché il curare il sintomo, e quindi la malattia, con ciò che è contrario significa entrare in un vizio di sistema: l’azione del rimedio viene provata dalla premessa patologica assiomaticamente accettata e la premessa patologica prova l’azione del rimedio. Il tutto diventa spesso un approccio meccanicistico e quasi acritico.
I medicamenti che egli adoperava sono praticamente erbe, minerali ed estratti di animali. L’arte della preparazione era però eccellente tanto che ancora oggi si definisce galenica la preparazione del medicamento in farmacia. Purtroppo sono andati persi molti di questi volumi e quindi Galeno viene ricordato più per la parte anatomodiagnostica che per la parte terapeutica. C’è un Galeno poco conosciuto, che è il filosofo. Egli credeva nell’esistenza di un unico essere superiore, creatore di ogni cosa. Era monoteista convinto, probabilmente derivante dagli studi in Alessandria.
La sua fede, il suo entusiasmo, la sua adorazione per questa divinità unica sono sentimenti così nobilmente espressi da essere riportati anche nei testi religiosi. “Veneriamo adunque ed esaltiamo la bontà del Creatore” ebbe a dire in uno dei suoi trattati: Galeno, il maestro dei secoli futuri, rimane quella autorità il cui detto suonò come dogma per oltre quindici secoli e ancora oggi stupisce i medici moderni. Ars medica come massima espressione della conoscenza sulle malattie: un percorso sempre in salita, mai in discesa.